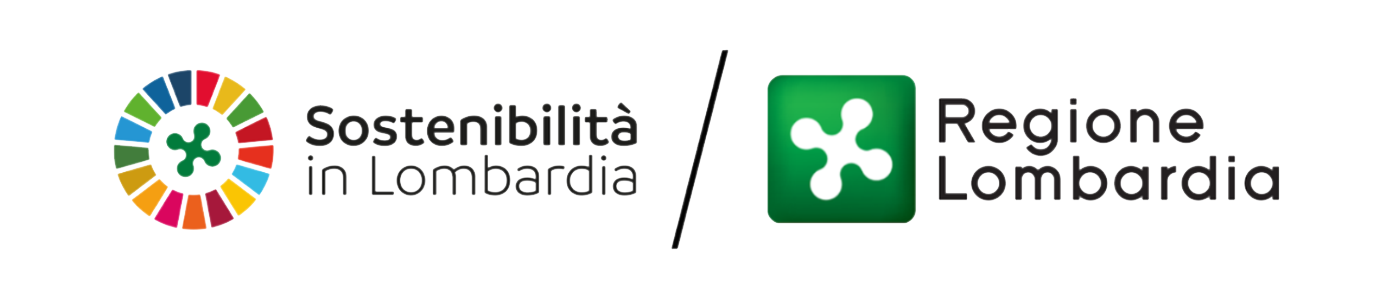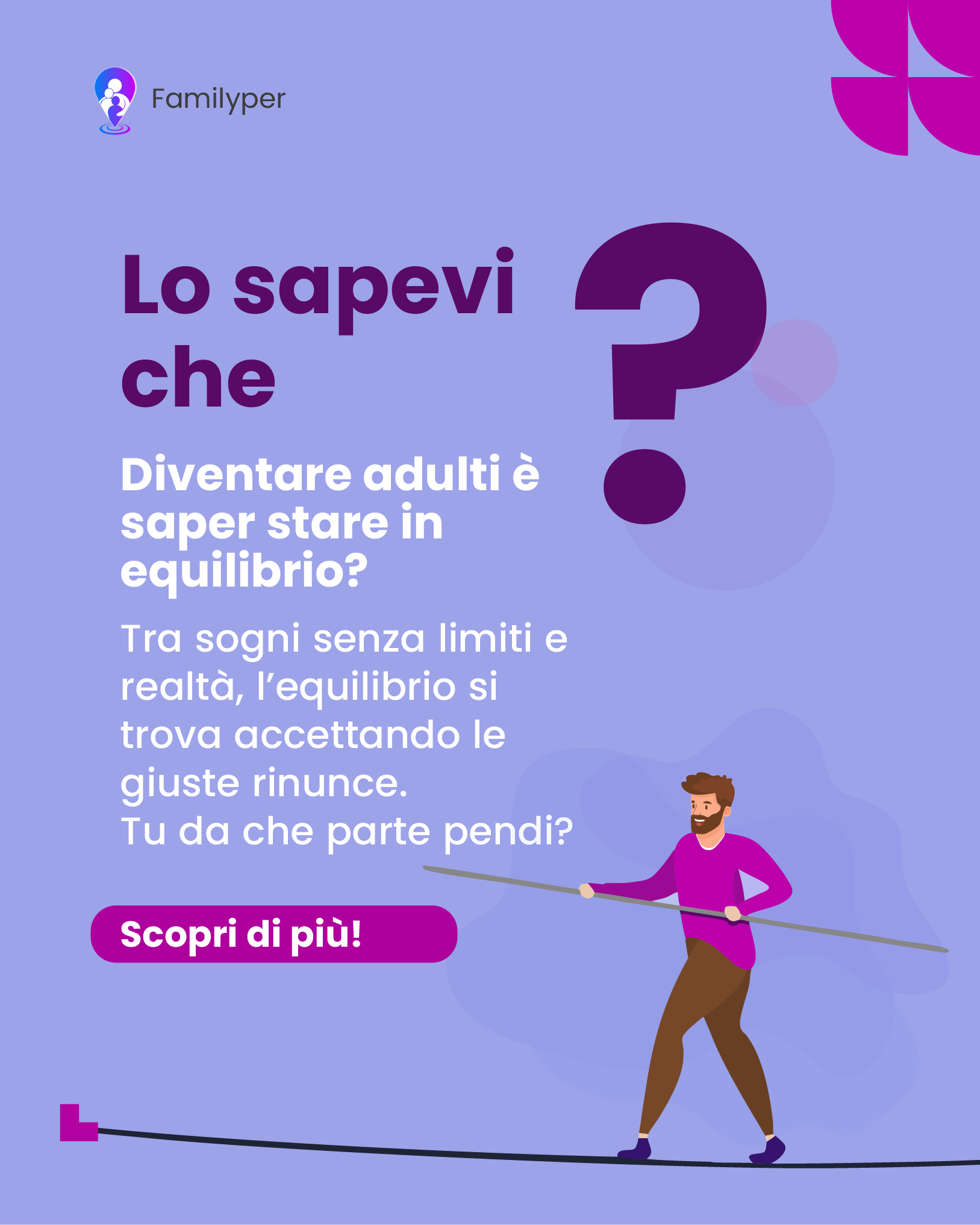
Collocata tra la fine dell’adolescenza e l’inizio dell’età adulta, la fase del “Giovane Adulto”, un concetto sostanzialmente nuovo nella letteratura psicologica e sociologica, lascia ancora dei dubbi sulla propria identità: si tratta, effettivamente, di un momento specifico e definito del ciclo di vita oppure di un periodo che semplicemente fa da “ponte” tra due età? Oppure si tratta semplicemente di una definizione che ci permette di essere più accomodanti nei confronti di coloro che, compiuta la maggiore età e non avendo ancora raggiunto gli “-anta”, non sono ancora riusciti a conquistare alcuni traguardi fondamentali dell’adulto?
Il punto di vista della Ricerca Sociale
Storicamente la ricerca sociale ha individuato diverse acquisizioni che decretano il raggiungimento dell’età adulta: l’uscita dal mondo della formazione (Scuola Superiore, Università), l’inserimento nel mondo del lavoro, l’indipendenza abitativa, il matrimonio o la convivenza, la nascita di un figlio.
Si tratta di una serie di tappe che, fino a qualche decennio fa, era difficile “mancare”. Oggi, con le trasformazioni socio-culturali, economiche, la precarietà lavorativa, il maggiore accesso delle donne al mondo dell’istruzione, la mancanza di evidenti riti di transizione e (talvolta) la debolezza delle funzioni normative, l’applicazione di questo percorso evolutivo risulta estremamente più difficile.
Cavalli e Galland (1996) individuano tre tipologie di modelli famigliari: quello inglese, quello francese e nordeuropeo e quello mediterraneo.
Quest’ultimo – che viene qui approfondito per nostra appartenenza geografico-culturale – si caratterizza da una lunga permanenza nella casa dei genitori da parte dei giovani adulti, dunque da una prolungata dipendenza (economica, affettiva, gestionale) da loro e di conseguenza da un posticipazione delle tappe evolutive sopra descritte.
Risulta altresì corretto non scadere in una banale generalizzazione, evidenziando come ciascun individuo possieda caratteristiche (personali, famigliari, ambientali) diverse che rendono ciascun percorso di crescita verso l’età adulta sempre più soggettivo.
Se da un lato risulta fondamentale considerare la specificità del percorso di ognuno, dall’altro lato è proprio da qui che si origina la difficoltà nel trovare una definizione comune per questa fase della vita.
La prospettiva Psicologica
La specificità dei percorsi individuali causa, inoltre, una certa fatica nel costruire in ambito clinico efficaci linee guida per il trattamento e la presa in carico del giovane adulto.
Alcuni autori suggeriscono che quella del “Giovane Adulto” non sia una fase della crescita a sè, ma che rappresenti la prosecuzione di un blocco evolutivo avvenuto durante l’adolescenza.
In effetti, questa età è spesso caratterizzata da un mancato completamento dei compiti di sviluppo tipici della fase precedente, compiti che se fossero stati portati a termine avrebbero garantito il lasciapassare per l’adultità: autonomia, indipendenza, sicurezze interne, separazione (fisica, emotiva, psichica) dalle figure genitoriali, consolidamento della propria identità, oltre alle tappe descritte nel paragrafo precedente.
Un nuovo romanzo di formazione
Cresciuti a scuola con i grandi classici del “romanzo di formazione” (“Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Il giovane Holden”, “David Copperfield”, ma anche la saga di “Harry Potter”), la strada che oggi percorrono i giovani verso l’età adulta sembra procedere al contrario.
Se i protagonisti ideati da Foscolo, Salinger, Dickens e Rowling dovevano infatti “acquisire” (abilità, conoscenze, competenze) per diventare grandi, i giovani di oggi devono “perdere”. Complici le recenti trasformazioni economiche e socio-culturali sopra citate, l’accesso al mondo adulto di oggi, infatti, implica una serie di rinunce: agli ideali, alle fantasie infantili di onnipotenza, illimitata realizzazione, potere assoluto sul proprio destino e sul proprio sè.
Tale necessità può esitare in due traiettorie evolutive opposte.
Da un lato la negazione di tale necessità (di rinuncia, di scendere a patti con la realtà e con le richieste della società per poter crescere), che genera “eterni adolescenti”. Si tratta di quei giovani in stallo, spesso visti da fuori come indecisi e perditempo (ma che in realtà vivono una profonda sofferenza legata alla paura di perdere, insieme alle “confortanti” sicurezze infantili, anche se stessi). Complice, a onor del vero, il messaggio trasmesso talvolta dagli adulti, che restare eternamente giovani e non del tutto definiti sia il mezzo più efficace per sentirsi liberi.
Dall’altro lato, più auspicabilmente, una funzionale accettazione di tale necessità, dove la perdita e la rinuncia implicano la possibilità di accedere al mondo adulto con nuove, realistiche, consapevolezze. Scendere a compromessi con il reale (e con i limiti che comporta) rinunciando all’ideale, non significa dunque “sprecare il proprio patrimonio di risorse”, ma farne buon uso riconoscendo quelle più funzionali alla propria realizzazione. Significa abbandonare l’illusoria – e falsa – idea di un sè illimitato in un mondo senza limiti per abbracciare la realistica idea di un Sè (fisiologicamente) limitato in un mondo che – per sua natura – dei limiti li ha.
E’ solo percorrendo questa seconda traiettoria che, dunque, il giovane adulto può acquisire un solido assestamento identitario e di conseguenza una soddisfacente realizzazione sociale, lavorativa e sentimentale.
Non senza fatiche…: ve ne parliamo nel prossimo articolo!